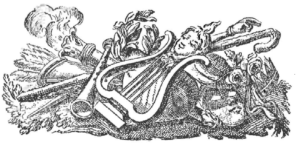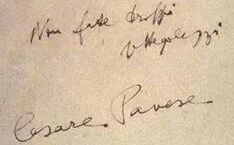Ogni qual volta si consuma uno stato di crisi, inesorabilmente la civiltà occidentale tende all’antico. Basti pensare all’arte del secondo novecento, all’atteggiamento assunto dalla maggior parte degli italiani in corrispondenza con le disillusioni seguite alla fine utopica del 1968.
Con alcune anticipazioni che meditavano l’arte rinascimentale e barocca nei primi anni sessanta (Giulio Paolini, E, 1963; Claudio Parmiggiani, La notte, 1964, Giosetta Fioroni, Nascita di una Venere, 1965), la più parte dei nostri artisti ritornava alla civiltà greca e romana nel furore della contestazione (Michelangelo Pistoletto, Venere degli stracci, 1967), calcinando la propria arte nell’esercizio del multiplo, emulo postmoderno della copia da originali ellenici.
Nell’ambito della moda gli stati di crisi spesso corrispondono con fenomeni di androginia e cross dressing che avvicinano fortemente maschile e femminile in un unico spettro performativo. Anche qui gli esempi non mancano. Facile ricordare la civiltà Hippy in quegli anni formidabili, quando si sperimentava la caduta delle barriere sessuali in seno alla famiglia, tra gli studenti, tra gli operai, immaginando un futuro di pace universale contro l’atomica, la guerra fredda, la Corea, il Vietnam.
Era un periodo di conflitti profondi che metteva contro padri e figli, situazione antiborghese che, da adolescenti, almeno una volta nella vita abbiamo sperato di vedere risolta in un finale alla Zebriskie Point (1970). Allora i ragazzi e le ragazze indossavano, sui capelli lunghi e gli ornamenti etnici, pantaloni a zampa d’elefante, camicie di tela indiana, ponchos ed eskimi. Ma si trattava di abbracci irrisolti che nel lungo periodo hanno generato, loro malgrado, ulteriori livelli di conflitto e incomunicabilità. In tal senso è emblematico The nude restaurant di Andy Wahrol (1967), dove l’apparente libertà dei corpi di due giovani amanti stride con la povertà e l’omologazione linguistica, verbale e sensuale al lessico dei consumi in un volgare fastfood.
Per ritrovare un contesto in cui femminile e maschile si confondono, lasciandoci intravedere un ‘futuro anteriore’ di soli pari, senza più conflitti di genere, finalmente uniti in un unico afflato, bisogna risalire ai miti di fondazione culturale dell’antica Grecia. Il passo più elevato è un noto discorso di Aristofane, riferito da Platone nel Simposio (Platone. Opere complete, Laterza ed., Roma-Bari 19885, vol. 3, XIV, 189-190, p. 165):
Bisogna innanzi tutto che sappiate qual è la natura dell’uomo e quali prove ha sofferto; perché l’antichissima nostra natura non era come l’attuale, ma diversa. In primo luogo l’umanità comprendeva tre sessi, no due come ora, maschio e femmina, ma se ne aggiungeva un terzo partecipe di entrambi di cui ora è rimasto il nome, mentre la cosa si è perduta. Era allora l’androgino, un sesso a sé, la cui forma e nome partecipavano del maschio e della femmina: ora non è rimasto che il nome che suona vergogna.
In secondo luogo, la forma degli umani era un tutto pieno: la schiena e i fianchi a cerchio, quattro bracci e quattro gambe, due volti del tutto uguali sul collo cilindrico, e una sola testa sui due volti, rivolti in senso opposto; e con quattro orecchie, due sessi, e tutto il resto analogamente, come è facile immaginare da quanto s’è detto. […]. Dunque i sessi erano tre e così fatti perché il genere maschile discendeva in origine dal sole, il femminile dalla terra, mentre l’altro, partecipe di entrambi, dalla luna, perché anche la luna partecipa del sole e della terra.
Dal mito antropogonico in avanti, i tentativi più concreti di dar nuova vita a un essere primigenio non dimediato sono stati compiuti, a mio avviso, dalla civiltà dandy. Risuona ancora l’auspicio di Jules A. Barbey d’Aurevilly (Del Dandysmo e di George Brummel, a cura di Mario Ubaldini, Passigli Ed., Firenze 1993, p. 102), che auspica per la futura umanità un egalitarismo di genere trascendente le differenze sessuali:
Nature doppie e multiple, di sesso intellettuale incerto, nelle quali la grazia è ancor più grazia nella forza, e la forza si riconosce anche nella grazia, androgini della Storia, nonché della Favola, e dei quali Alcibiade fu il tipo più bello nella più bella nazione.
L’autore ci prospetta una precisa via: l’insieme dei lineamenti nell’essere perfetto non dovrà apparire fisico o psicologico ma noetico e culturale. Il dandy è androgino nella testa più che nel corpo, figura estetica con la sostanza divina di chi ha elevato il proprio spirito oltre i limiti della carne, quale che essa sia. Come un asceta bizantino, lui/lei ci invita a entrare nudi e angelicati nello spazio sacro di una religione laica senza tempo.
A tal proposito, mi pare che un giovane brand incarni meglio di altri la lunga sinusoide della civiltà dandy nel contemporaneo: Casa Preti, fondata a Palermo nel 2017 da Mattia Piazza e Steve Galley. Il marchio propone un’allure fondata sul principio d’indeterminatezza derivante dalla lezione platonica originaria.
Nella collezione A.I. 2020/21 dal significativo titolo Ama, essa mette a nudo la propria matrice non dimediata, richiamando nelle proposte maschili e femminili una serie di tratti condivisi, facendosi portavoce di una missione culturale più volte annunciata nei sistemi di moda contemporanei ma mai pienamente accolta.
Casa Preti affida il tema dell’androginia alla doppia radice semantica della destrutturazione e dell’empatia, con riferimenti iconografici all’essere platonico primigenio, d’un lato, alle Connessioni (1967) e ai Canali segnici (1968) di Franz Erhard Walther, dall’altro. Essa affonda le mani nell’indeterminatezza di genere che ha caratterizzato alcuni momenti della nostra età moderna, indeterminatezza che nella moda è possibile accostare al bisogno di classicità nei tempi di crisi.