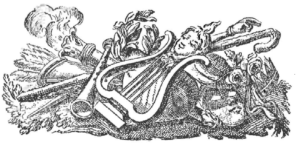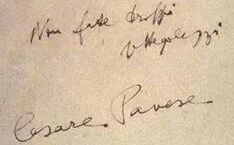Una giovane artista iraniana ci porta nel campo confuso dell’umanità, incerta ma intellegibile fusione del complicato diorama antropologico che caratterizza le società contemporanee. Nei suoi quadri alberga una folla di uomini e donne al limitare continuo tra due opposti: conflitto-pace, incomunicabilità-dialogo, sopruso-compassione, distanza-prossimità.
Rasta Safari, in arte Rasta (Mashhad, Iran 1988) è un’artista ormai confermata nel ruolo di cantrice della condizione umana nell’età degli esodi. I suoi quadri sono un continuum di “dramatic close-up” sulle angosce derivanti alle genti nell’indeterminatezza del proprio futuro. Eppure, dalla scarificazione dei suoi visi affollati emerge sempre un barlume d’amore, di speranza, una nuova possibilità.
Qualcosa che dalla tradizione iconoclasta islamica si sposta lentamente verso quella iconografica cristiana, dando corpo alla speranza più di qualsiasi parola scritta. Le sue ultime prove si assottigliano verso la tradizione pittorica e scultorea occidentale; con inquadrature sempre più serrate, Rasta medita la grande tradizione patetica europea e la fa propria, affogandola in una densa materia di colori plumbei; la sacralità della vita, l’oscenità della morte, la possibilità interstiziale della salvezza.
Posti di fronte ai suoi ‘senza titolo’ del 2021 si resta raggelati come dinanzi a un girone dantesco. Folle di esseri sottili come lemuri calcano la scena, quasi levitando nell’aria opprimente dei grigi, dei blu, dei rossi violacei. Le figure sono contornate da tratti duri e incisori, gli unici in grado di contenere e dare sostanza ai corpi, altrimenti destinati a svaporare.
Altri segni netti e decisi fasciano i sembianti richiamando la condizione di perenne medicalizzazione delle società contemporanee, oppure, agli estremi, alcune pratiche di sepoltura. Ma dalla condizione angosciosa di quelle anime in pena emerge sempre uno stato di grazia primordiale; nei personaggi che ci guardano come richiamati dalla nostra attenzione c’è una dolcissima gentilezza, come un fraterno monito e avvertimento.
Dal punto di vista pittorico non sarà difficile individuare le tradizioni a cui Rasta attinge. Nella serie si scorgono tratti michelangioleschi, impastati della stessa materia che componeva le opere di Klimt, e poi ancora dell’aktionista Schwartzkogler, passando per il Simbolismo di Redon e Moreau, per l’Espressionismo di un Nolde o di un Kokoschka.
Le stesure devono molto alla tradizione incisoria, la fluidità e tavolozza riecheggiano le infinite mescolanze dei vetri o degli smalti fusi (in età giovanile l’artista si è interessata di cromatologia). I suoi scavi pittorici devono tanto agli studi psicoanalitici di Freud e di Jung; in definitiva, la sua visione del mondo non differisce molto dall’adagio shakespeariano secondo cui la natura umana sarebbe intrisa di sogni.
Persiana di nascita, italiana per formazione, con una fortuna espositiva e critica già ragguardevole, Rasta Safari è destinata a fare discutere molto di sé e della sua opera, intensa e magistrale. In questo scorcio di 2021 lei testimonia la possibilità del dialogo, dell’accoglienza e della responsabilità che le nostre istituzioni accademiche hanno nei confronti dei giovani artisti mediorientali.
Lei che si è formata presso la Facoltà d’arte dell’Università di Zahedan in Iran, quindi alle Accademie di Belle arti di Catania (ricordo una splendida allieva) e di Roma, è l’archetipo ideale di un modello virtuoso che anche oggi si ripete. Dovremmo dire “di scambio” e “interculturale”, ma purtroppo non sempre è così.
È degli ultimi giorni la notizia secondo cui alcune accademie italiane si starebbero adoperando per istituire borse di studio in favore di giovani artisti in fuga dall’Afghanistan. In questo tragico caso la direzione sarà una e una soltanto, ma darà la misura del ruolo storico svolto dall’Italia nell’affermazione della civiltà umanistica, con l’augurio che dalla paura e dall’oppressione dei popoli nasca sempre e comunque la vita.