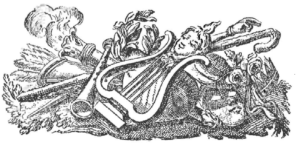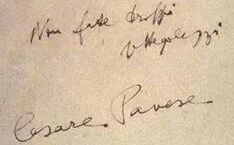“Questo non è un racconto”. È questo il titolo di un inedito di Leonardo Sciascia. L’editore Adelphi lo pubblica in occasione del centenario della nascita dello scrittore di Racalmuto. Un rimando a un’opera di Denis Diderot: “Ceci n’est pas un conte”, pubblicata nel 1772. Un titolo e una storia, che sintetizzano Sciascia e il suo inconfondibile narrare.
L’anniversario del centenario sciasciano è il tripudio di ricordi, riedizioni, mostre, convegni, dibattiti, streaming, lenzuolate dei giornali, aperture dei Tg, maratone radiofoniche. Ma soprattutto, il continuo fiorire di amici. Tanti amici. Quanti non ne aveva mai avuti in vita lo scrittore più eretico del Novecento italiano. Chissà cosa penserebbe Sciascia di questo tripudio. In vita, avversò ogni Chiesa, quella cattolica e quella comunista. Era contrariato dall’untuosa pratica italica di adorare santini, rendere omaggio solo dopo la morte. Ammonimento che lo scrittore siciliano pubblicò subito dopo la tragica scomparsa di Pier Paolo Pasolini. La stessa esortazione di Alberto Moravia nel corso del tragico funerale del poeta.
Dunque, questo non è un racconto, è il rimando a un grande scrittore francese. I suoi amati autori francesi. Tutti i suoi libri partivano quasi sempre da un repêchage. Questo titolo e il libro di Diderot, non sono casuali. La risposta nelle parole del filosofo francese: “Si incontravano di rado, ma si scrivevano spesso. Io cento volte ho ripetuto agli amanti: non scrivete, le lettere saranno la vostra rovina; casualmente, qualcuna, prima o poi, finirà all’indirizzo sbagliato. Il caso dà origine a tutte le possibili combinazioni di eventi e non gli occorre che del tempo per determinare quella che risulterà fatale. Qualcuno vi ha mai dato retta? E tutti hanno trovato la loro rovina”.
La storia è incentrata sulla disdicevole pratica dei giudizi, quasi sempre avventati e a sproposito. Chissà, forse era questo il monito finale dell’inflessibile Sciascia. Metteva in guardia dal rischio di fraintendimenti e giudizi, quasi sempre avventati e a sproposito. Forse, anche queste righe. Leonardo Sciascia era diffidente, fu guardingo per tutta la vita. Inviso ad ogni consorteria, gilda, corporazione, setta, fazione. Fu splendido eretico, permaloso, tenace, inflessibile. Come il suo fra Diego La Matina, protagonista di “Morte dell’inquisitore”. Un eremita condannato per eresia. Nel 1657, rinchiuso nelle carceri dell’Inquisizione a Palermo, durante un interrogatorio, ghermì con le manette il grande inquisitore della Sicilia, Juan Lopez de Cisneros, uccidendolo.
Ecco, questa è stata la cifra stilistica della scrittura sciasciana. Lo scrittore, l’intellettuale, inteso come l’homme révolté di Camus. Questo considerazioni, non già per incarnare voci fuori da coro. Sarebbe anche questo un vacuo esercizio di stile. Piuttosto, un invito guardingo alle parate mielose e caramellate.
Sulle sue opere sono stati versati i classici fiumi di inchiostro. Ma cosa hanno rappresentato Sciascia e i suoi libri, per le generazioni che si sono formate nel corso degli anni Sessanta? Quale è stato il contributo di questo straordinario personaggio per un territorio eccentrico come la Sicilia dell’entroterra e il Meridione? Che valore ha avuto la sua scrittura di intervento, il suo dettato esplicito, la ricerca della verità? Ecco, forse sono questi utili interrogativi.
I libri di Sciascia, sono stati la formazione morale per generazioni di figli e nipoti di contadini, minatori, gabellotti, operai e artigiani, maestri di scuola. Erano i primi volumi che entravano in quelle case modeste, trovavano posto nelle librerie di formica, tra gli scaffali dei tinelli. La sua, era scrittura che non si faceva orpello, consolazione. La povera gente, annotava Sciascia nella premessa alle “Parrocchie di Regalpetra”, aveva una gran fiducia nella scrittura. Dicevano: “Basta un colpo di penna”. Come a dire: “Un colpo di spada”. Credevano che un colpo vibratile ed esatto della penna, potesse bastare a ristabilire un diritto, a fugare l’ingiustizia e il sopruso.
Ecco, questo ha incarnato la scrittura, la letteratura, la stessa figura dello scrittore di Racalmuto. La scrittura non orpello, né belletto ma strumento di conoscenza, di lotta, di redenzione. Arma con la quale combattere ingiustizie, sopraffazioni, imposture.
La scrittura era il riscatto di generazioni di vinti, sconfitti, ultimi. Molti, grazie a questo concetto, sono diventati magistrati, maestri di scuola, sindacalisti, politici, giornalisti, scrittori, artisti. Un sommovimento potentissimo, operato in un territorio, quello dell’entroterra siciliano immobile per secoli. Paesi dalle sonorità arabe: Milena, Delia, Serradifalco, Montedoro. A cominciare dalla stessa Racalmuto, Rahl al-mudd, villaggio morto. Erano i villaggi, i paesi degli zolfatari e dei salinari, formicole che si muovevano tra i camminamenti delle pirrere, le miniere dell’Italkali. Terre di stenti e di angherie secolari. Casupole di contadini che galleggiano in un mare di gesso e zolfo, come scrive Enzo D’antona.
Sciascia, in questi luoghi, assume financo una connotazione sonora altra. Con un accento posto a metà. In questo entroterra siciliano è Sciàscia, con un suono lieve e aspirato. Xaxa, che in arabo è il velo da capo. Qui era nato Sciascia l’8 gennaio del 1921. Sarebbe meglio dire, 1920+1, parafrasando il titolo del suo libro “1912+1”. Si, perché l’autore de “Il giorno della civetta”, era nato in realtà nel dicembre del 1920. Ma, per rubare un anno al re, suo padre lo dichiarò all’anagrafe nel gennaio del 1921. Un escamotage invalso a quel tempo per ritardare la chiamata alla leva. Ma, come si conviene ad un uomo predestinato al racconto, il buon Nanà sarà dichiarato rivedibile, poi riformato e non dichiarato idoneo per il fronte.
La scrittura di Sciascia appare così particolare, insolita, eccentrica in una regione densamente popolata da autori barocchi e trabordanti. Quei libretti erano esili, essenziali. Si narra che una giornalista di grido, sottolineò con una certa sufficienza, la mancata corposità di uno dei volumi di Sciascia, appena pubblicato. E lui, accendendo l’ennesima sigaretta, aguzzando i suoi occhi aggrottati, sentenziò che era la verità. Quella magrezza però, gli era costata la fatica di un anno di scrittura e un successivo anno di sintesi.
Memorabili questi aneddoti sciasciani. Episodi che allontanano l’immagine stereotipata dell’intellettuale ingrigito e triste. In realtà, un uomo di spirito, attento osservatore. Ma era anche un uomo tutto di un pezzo, aspro. Come testimonia la rottura della storica amicizia con il pittore Renato Guttuso. Un episodio che, da solo testimonia il periodo storico e le due visioni del mondo. Da una parte Guttuso, intellettuale engagé. Dall’altra, l’eretico Sciascia. Da una parte il militante comunista che, con sofferenza, difende l’indifendibile posizione del suo partito. Dall’altra, l’homme révolté, che non ha nessuna intenzione di negare l’evidenza a favore di nessuna Chiesa. Un errore, che la Sinistra italiana pagò caro. Fino a giungere al tardivo e onesto ravvedimento di un suo dirigente storico, Emanuele Macaluso che, di recente, ha pubblicato un libro dal titolo: “Leonardo Sciascia e i comunisti”.
Questo è un racconto, invece. Narra di un viaggio da Serradifalco a Caltanissetta. Una strada tutta tornanti guadagnata a bordo di una Fiat 1100, guidata dal maestro elementare Salvaore Petix. I capelli, annegati in un doppio strato di brillantina Linetti. I pesanti occhiali di bachelite. La cartella di cuoio. La vettura gremita da un numero imprecisato di suoi studenti. La leva del cambio che gratta scalando le marce. L’arrivo in piazza Garibaldi a Caltanissetta. Il plotone di serradifalchesi, guadagna il corso Umberto I. Non prima di una sosta ai tavolini del mitico caffè Romano. Un assalto, ai limiti della lussuria, ai rollò con ricotta, fino a guadagnare la perla di pasta reale incastonata al centro. La marcia degli intrepidi riprende. Pochi metri, a sinistra del monumento equestre al re piemontese, le vetrine della libreria di Salvatore Sciascia. L’appuntamento è con il direttore della rivista “Galleria”. Dopo l’ampio stanzone invaso di libri, un pertugio in fondo. Una saletta, minuscola quanto uno stato d’animo. A stento, tra le volute di una coltre di fumo indefinibile, un signore minuto, l’eleganza composta. Accenna un sorriso socchiudendo gli occhi. Aspira con avidità la bianca Chesterfiel, e sembra svanire nella nuvola color tortora.